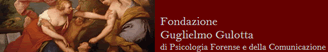Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
Avv. Pierluigi Varischi
Avv. Salvatore Pino
Avv. Ivan Frioni
Avv. Pierluigi Varischi
Avv. Salvatore Pino
Avv. Ivan Frioni
Avv. Andrea Righi
Avv. Luigi Plati
Avv. Daniele Domenichelli
Avv. Matias Manco
Avv. Marco Farina
Avv. Lorenzo Zirilli
Avv. Paolo Della Noce
Avv. Fabio Re Ferrè
Dott. Antonio Leo
Dott. Davide Lucini Paioni
Avv. Luigi Plati
Avv. Daniele Domenichelli
Avv. Matias Manco
Avv. Marco Farina
Avv. Lorenzo Zirilli
Avv. Paolo Della Noce
Avv. Fabio Re Ferrè
Dott. Antonio Leo
Dott. Davide Lucini Paioni
CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO - INSUSSISTENZA (art. 368 c.p)
Corte d’appello di Milano, 2a sezione penale, Pres. R. Pallini, Udienza del 28 marzo 2002, dep. 05.04.02.
Non sussiste il reato di calunnia per carenza dell’elemento soggettivo se, al tempo della denuncia, manca nel soggetto agente la piena consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.
La mera e generica denuncia alla polizia di aver subito dall’amante, nell’ambito di una relazione extraconiugale, una richiesta di soldi con la minaccia di divulgare alla figlia dell’interessato e nei luoghi di lavoro frequentati dallo stesso la notizia della relazione, precisando nella denuncia di essersi poi conseguentemente determinati a consegnare la somma all’amante con la speranza che il ricatto potesse cessare, non configura gli estremi della calunnia se appare evidente che l’imputato aveva inteso, rivolgendosi ai Carabinieri, denunziare una situazione di pressione psicologica ma non di vera e propria intimidazione, evidenziando così che all’epoca della denuncia non era consapevole di aver incolpato l’amante di un reato.
La prova della mancata volontà dell’incolpare un soggetto di un determinato reato nell’ambito dell’accertamento della calunnia può essere desunta anche dalla circostanza che il giudizio sui fatti incolpati alla persona asseritamente calunniata sia terminato con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, e che il procedimento per calunnia sia insorto non tanto per segnalazione del Giudice ma per denuncia della persona asseritamente calunniata.
(dai motivi di appello del difensore)
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, caratterizzante la condotta dell’imputato quando denuncia il fatto di cui è causa, non può dubitarsi che l’itinerario valutativo risultante dalla sentenza sia soltanto apparente.
Il giudice di prime cure, attento ad attribuire credibilità alla persona offesa e tentando di precludere l’ingresso a supposti elementi irrilevanti (quali gli estratto conto de quibus), ha però omesso di verificare le specifiche caratteristiche del dolo di calunnia.
Le prescrizioni normative inerenti alla fattispecie in esame, per la natura del bene giuridico protetto e per l’effettiva finalità della previsione incriminatrice, richiedono che il soggetto agisca scientemente, sapendo della sussistenza di un determinato fatto, ovvero, ancora intenzionalmente, formuli la falsa accusa avendo la certezza dell’innocenza dell’incolpato.
Orbene, questa certezza non può certo rinvenirsi in capo all’imputato il quale, di contro, esponendo nella denuncia de qua ciò che riteneva essere un pericolo concreto ed attuale, vale a dire le rivelazioni della parte civile, poneva a corollario della propria esposizione anche il sentire come non libera la propria volontà nell’elargire il danaro di cui è causa.
In realtà, l’imputato viveva in una situazione di conflitto interiore tale da non consentirgli di agire con la lucidità che lo ha sempre caratterizzato, ed infatti, egli cedeva alla pretesa economica avanzata dalla parte offesa.
L’intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato sono due dati che vanno tenuti concettualmente distinti, non foss’altro perché l’accusa di aver commesso atti penalmente illeciti è situazione ben diversa dalla conoscenza della non colpevolezza tanto da inferirne che non è sufficiente ad integrare il dolo di calunnia la scarsa convinzione in ordine alla responsabilità del soggetto accusato (Cass. Pen. sez. VI, sent. n. 9853 del 10.07.2000, imp. Cotronei).
In riferimento a quanto precedentemente sostenuto, risulta evidente che il Giudicante ha emarginato la rilevanza di quei momenti che, nella fase rappresentativa dell’imputato, si siano presentati disomogenei rispetto alla sequenza volitiva, non avendo nemmeno valutato, peraltro, che il dubbio sulla responsabilità della parte civile, nei cui confronti vengono rivolte le accuse, sia idoneo ad escludere che la condotta dell’imputato presenti una qualsivoglia forma di dolo.
Al riguardo, significativo risulta poi rimarcare che la più recente giurisprudenza ha ritenuto che la tendenziosità della denuncia non dimostra di per sé la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato da parte del denunciante (Cass. Pen. sez. VI, sent. 02.07.1998, Perrotta). Ed ancora, tale consapevolezza è in re ipsa, ma nel senso che è evidenziata dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che connotano la condotta tenuta, dalle quali è possibile, con processo logico-induttivo, risalire alla sfera intellettuale e volitiva dell’agente; in sintesi, la sussistenza del dolo si immedesima con l’accertamento della cosciente falsità delle circostanze oggetto della denuncia (Cass. Pen. sez. VI, sent. 19.11.1998, Farina; Cass. Pen. sez. VI, sent. 14.05.1999, De Bartolomeo).
Conformemente a quanto sopra rilevato, per ciò che concerne l’elemento soggettivo, è pacifico in giurisprudenza che il dolo de quo richiede l’immanente consapevolezza non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole (in tal senso, v. Cass. Pen. sez. VI, sent. 12.04.1995, Leone). Ed ancora, la certezza dell’innocenza dell’incolpato costituisce l’essenza del dolo e deve essere piena ed assoluta nel momento in cui l’incolpazione ha luogo (Cass. pen. sez. V, sent. 21.05.1992, imp. Chirico, in Giust. pen. 1993, II, c. 296).
Si rende pertanto necessaria una prova di resistenza tra la sentenza di assoluzione della parte civile e le altre risultanze processuali; detta sentenza, infatti, non può essere utilizzata quale elemento scagionante la condotta attribuita alla parte civile dall’imputato.
Giova inoltre in tal senso evidenziare che la stessa parte civile, nel procedimento originato dalla denunzia dell’imputato, è stata prosciolta perché il fatto non costituisce reato e non perché il G.U.P. avesse ritenuto che quella condotta fosse insussistente.
Egli infatti se avesse evidenziato l’inesistenza del presupposto denunziato dall’odierno imputato avrebbe avuto l’obbligo di rimettere gli atti al Pubblico Ministero affinché questi procedesse poi per il reato di calunnia.
Ma così non è stato, posto che lo stesso G.U.P. non ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo propri della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 368 c.p..
Pro
Guglielmo Gulotta e Pierluigi Varischi